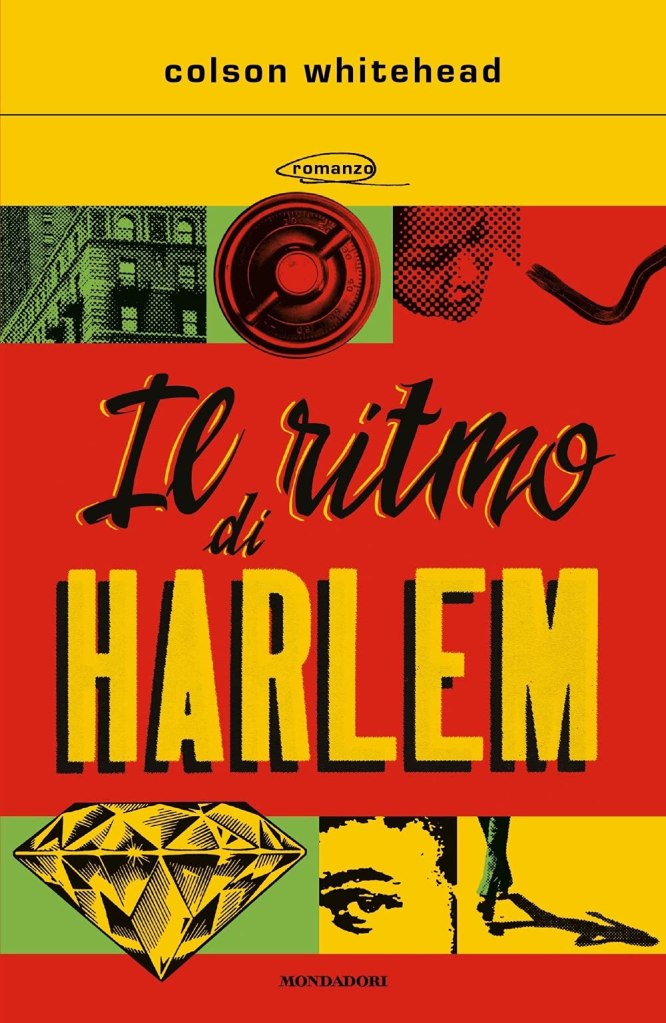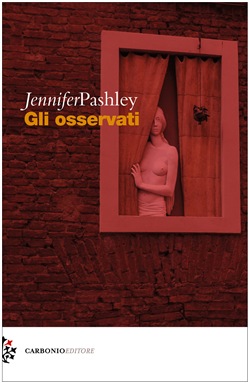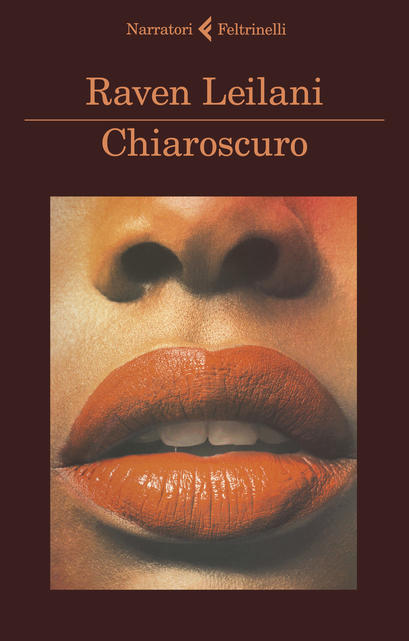Faccio ammenda,
qualche anno fa, dopo aver letto lo splendido L’Uomo Verticale, avevo rinchiuso Davide Longo nello scrigno degli autori “emozionanti”, quelli capaci di lasciare un solco profondo nella carne viva di un lettore seriale come il sottoscritto. La volontà di preservare più a lungo possibile il sentimento di profonda riconoscenza nei suoi confronti, scaturito da quella lettura così potente e ben architettata, mi ha portato ad allontanarmi da ogni suo scritto successivo, nel timore che i nuovi contenuti avrebbero potuto sminuire la portata della mia considerazione nei suoi confronti.
Essì, sono cervellotico ed egocentrico, ne sono fieramente consapevole, ma stavolta ho rimediato tuffandomi senza remore tra le braccia flosce ma “apparentemente” sicure di Vincenzo Arcadipane e compagnia bella.
La vita paga il sabato, edito da Einaudi, è il quarto libro che vede come protagonisti il Commissario Arcadipane e il suo ex capo Corso Bramard. La coppia, collaudata e magistralmente caratterizzata da Davide Longo, questa volta allarga i propri orizzonti territoriali e umani, spaziando dalla ruvida diffidenza delle montagne piemontesi fino alla dissoluta freneticità romana.
Terenzio Fuci, ottantaseienne produttore cinematografico viene ritrovato morto nella sua Jaguar in una sperduta valle alpina. Di sua moglie, Vera Ladich, icona cinematografica per un’intera generazione, si sono perse le tracce. Le indagini vengono affidate al commissario Arcadipane che è costretto a lasciare Torino per trasferirsi a Clot, un pugno di case abitate da gente spigolosa e diffidente la cui esistenza è indissolubilmente legata all’enorme diga che circonda la valle. Nonostante la compagnia di Trepet, cane a tre zampe che sembra fatto apposta per mettere in imbarazzo il suo padrone, Arcadipane non riesce a trovare il bandolo della matassa e si affida ai suoi sodali di sempre, Il vecchio amico e mentore Corso Bramard e l’indisciplinata ma indispensabile agente Isa Mancini, entrambi alle prese con un momento difficile della propria vita. Non sarà semplice arrivare alla verità, nascosta tra le pieghe di segreti antichi e nuovi egoismi protetti da poteri apparentemente inviolabili.
La Torino di Arcadipane, dolce e amara come i sucai di cui va ghiotto, fatta di vecchie osterie e palazzine popolari, di interni acrilici e pensioni minime, qui è meno presente e lascia il posto alla montagna piemontese, aspra e poco incline all’utilizzo effimero della parola, fino a tracimare nel caos capitolino dove sentirsi fuori luogo è assolutamente nella norma.
Davide Longo, pur utilizzando in maniera rispettosa i tempi e i ritmi cari al noir, li amplia rendendoli assolutamente personali, come solo i grandi scrittori sanno fare, proseguendo così il suo percorso autoriale incentrato sulla rappresentazione di un’umanità stropicciata, dolorosa, sobria, apparentemente marginale ma estremamente efficace nel raccontare la nostra realtà.
La recensione è stata pubblicata su Milanonera